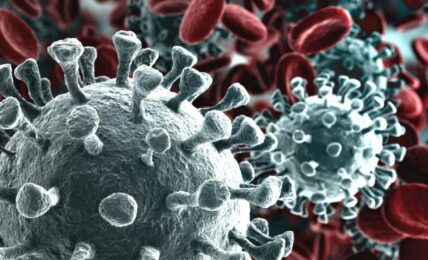«Forse siamo noi i veri mostri»
Intervista a Barbara Schiavulli, inviata di guerra e direttrice di RadioBullets: partendo dal suo ultimo libro, dedicato alle donne afghane, passando per i trafficanti di armi e di migranti. Un lungo viaggio che porta dritto al cuore di Kabul (e dintorni).