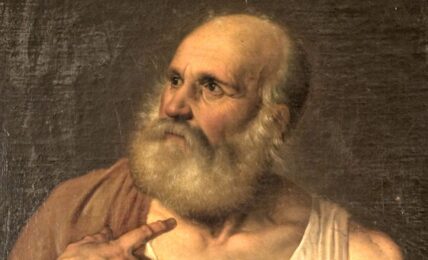Società di Colpa e Società di Vergogna
Ci sono ambienti ed epoche marcate più da un modello che dall’altro, ma in genere le forme convivono, specie nelle società complesse e stratificate come quelle in cui viviamo oggi. Ecco allora che la nitidezza dei paradigmi classici ci aiuta a comprendere noi stessi e il nostro mondo.