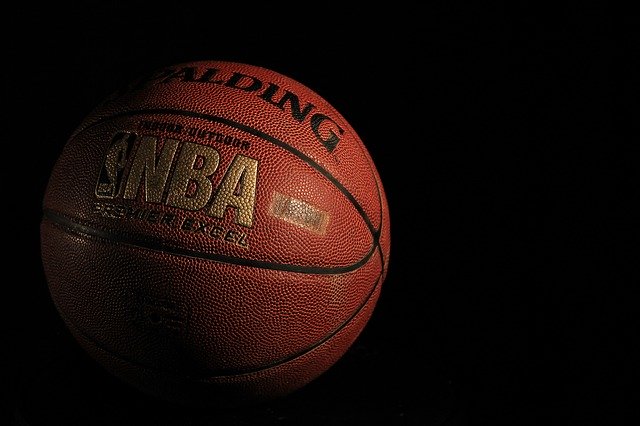Viva lo sport, la politica, evviva chi si schiera
Il mondo dello sport può essere una leva che innesca movimenti storico-culturali. I suoi protagonisti sono ancora capaci di incidere sul dibattito pubblico. Ma in Italia quando abbiamo perso di vista questo legame?