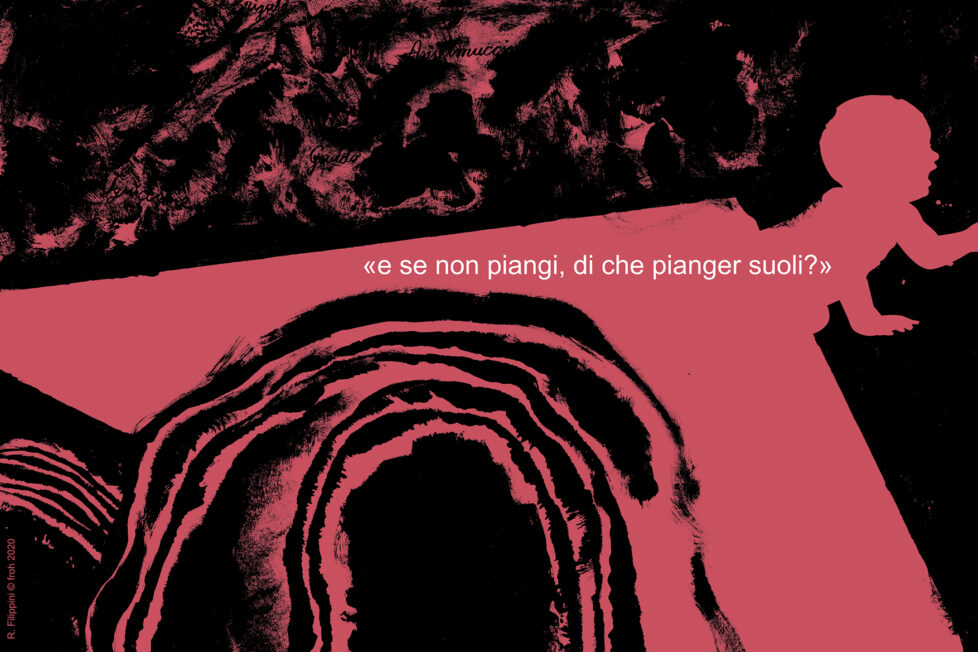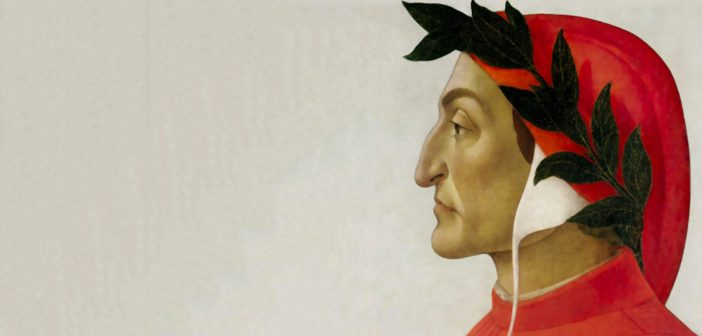La “petrasfera” di Dante
Torna la rubrica del dantista Mirco Cittadini, dedicata alle fake news sul Sommo Poeta. Questa volta prende di mira alcuni accostamenti che sono stati fatti fra una poesia dell'Alighieri e la recentissima serie tv di Netflix.