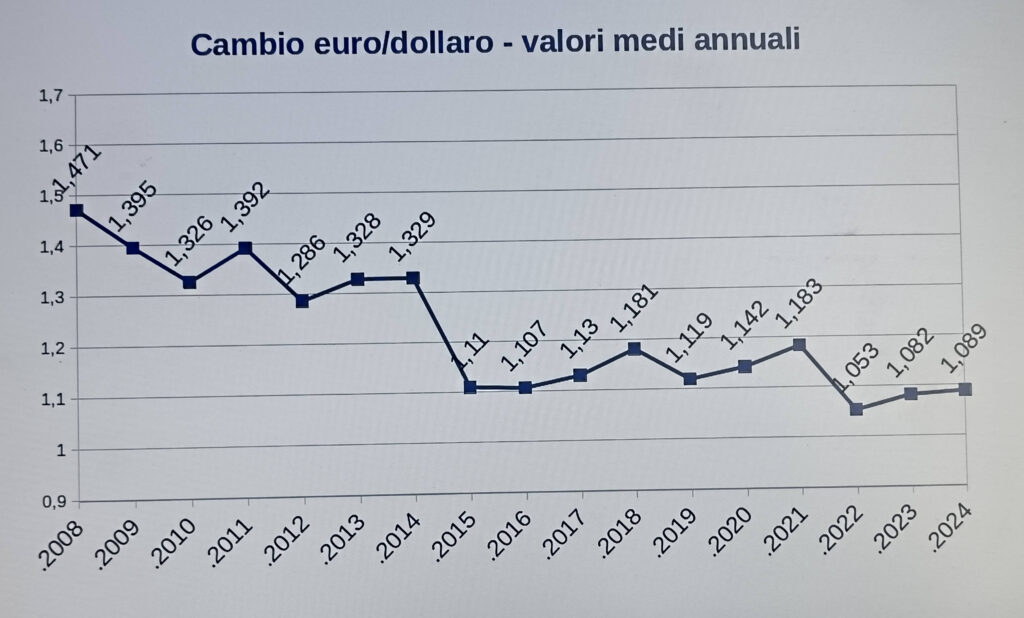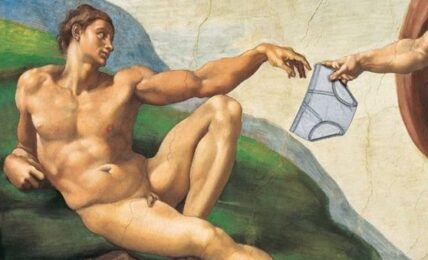La guerra dei dazi, una scomposta reazione agli squilibri globali
Donald Trump sta agendo in modo maleducato, sgangherato e presuntuoso sull’economia globale. Pur partendo da presupposti economici e obiettivi legittimi, non riuscirà a raggiungere i risultati sperati.