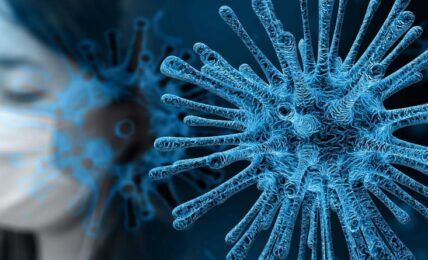Quando l’angoscia invade la quotidianità della vita
Il caso di Vigonovo ci sconvolge, ci coinvolge, ci interpella, perché siamo di fronte alla violenza del compagno di banco, dell’amico che frequentiamo sul treno, della persona che incontriamo tutti i giorni e con la quale percorriamo serenamente un tratto di vita, della quale mai avremmo potuto pensare che arrivasse oltre i limiti inferiori dell’umano.