«Il digitale? In Italia serve una rivoluzione culturale»
Per cambiare le cose nel campo della digitalizzazione informatica in Italia occorre molto più degli investimenti previsti nel PNRR. L'intervista a Lorenzo Lavarini, fondatore di CPartner.
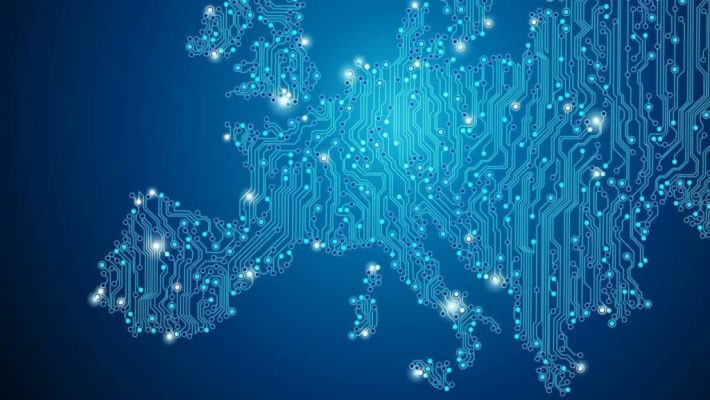
Per cambiare le cose nel campo della digitalizzazione informatica in Italia occorre molto più degli investimenti previsti nel PNRR. L'intervista a Lorenzo Lavarini, fondatore di CPartner.
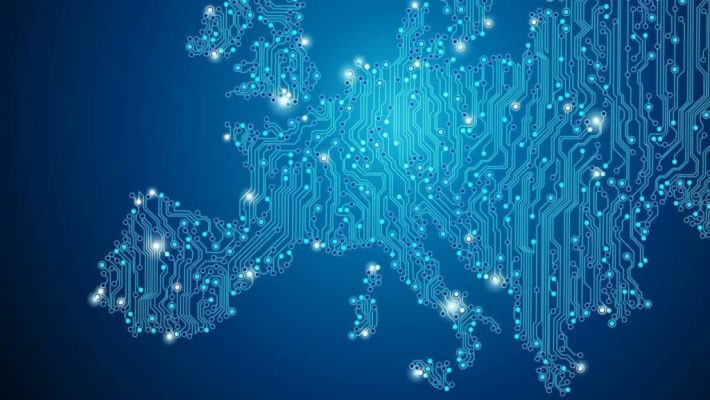
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedica al digitale 48 miliardi di euro, ben il 25% del totale, contro il 20% minimo chiesto da Bruxelles per la transizione digitale. Assieme ai fondi per la coesione di ‘React-Eu’, previsti nel meccanismo di ripresa del ‘Next Generation Eu’, e al contributo del Fondo complementare del Governo, l’Italia prevede di investire sulla digitalizzazione oltre 50 miliardi di euro entro il 2026. In base all’ammontare del contributo alla transizione digitale previsto dal Pnrr, l’Italia è al decimo posto tra i piani valutati finora dalla Commissione europea. Nell’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (Desi) elaborato dalla Commissione europea nel 2021, l’Italia è però al ventesimo posto totale su 27, davanti solo a Cipro, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Grecia, Bulgaria e Romania, anche se in in miglioramento rispetto al venticinquesimo posto al quale è risultata l’anno prima, cioè nel Desi 2020.
Un contributo, quello, che se sfruttato a dovere potrà risultare decisivo per ottenere quel passo in avanti necessario e da molti giustamente atteso. L’Italia, lo ha dimostrato proprio la crisi pandemica, è ancora molto arretrata in tema di tecnologia e non parliamo solo di quella di tutti i giorni, ma anche e soprattutto di quella delle nostre imprese. Ne parliamo con Lorenzo Lavarini, fondatore della ditta CPartner, esperto di informatica e del settore digitale.
Lavarini, negli ultimi anni, soprattutto a causa del Covid, le compagnie informatiche a detta di molti hanno avuto un vero e proprio boom. Per via dello smart working, ma non solo…
«La pandemia ha dimostrato l’impreparazione dell’impresa media italiana a gestire la mancanza di personale in azienda. Lo smart working è stato travolgente nelle prime settimane di pandemia, perché tutti volevano introdurlo nei propri processi produttivi. In questo senso c’è da dire che gli altri Paesi, come Francia e Germania, all’epoca erano già più avanti di noi nell’utilizzo di questa modalità. Adesso, finito il periodo di emergenza, il lavoro agile da casa è comunque rimasto uno strumento vitale per tante aziende, perché nel frattempo ci si è accorti di quanto possa essere utile alla vita dei lavoratori: alla madre che è a casa ad accudire i figli, ad esempio, o comunque a chiunque abbia esigenze di carattere familiare.»

L’Italia, insomma, è in ritardo…
«La chiave di lettura può essere affrontata da molti punti di vista. Se consideriamo la tipologia di utente e di quanto l’informatica permea oggi la vita dei privati cittadini, sicuramente in questi due anni abbiamo avuto un’esplosione di servizi, app, strumenti informatici e molto altro per avvicinare i cittadini alla tecnologia. Per il mondo business, invece, le cose sono diverse. Il mercato italiano soffre un po’ la vecchia concezione che considera ancora la tecnologia come una spesa non necessaria o comunque rimandabile, quando invece spesso è lo strumento che permette di fare quel salto di qualità fondamentale, che alla piccola media impresa oggi manca.»
Perché secondo lei?
«Manca la cultura. L’imprenditore medio fatica a comprendere le potenzialità in termini di efficienza lavorativa e comunicazione che l’informatica permette di raggiungere. Paradossalmente oggi nelle case private troviamo sempre più tecnologia, mentre nelle aziende il processo di adozione è troppo lento.»
Oggi tutti hanno uno smartphone. Cosa comporta, questo, per la nostra società?
«La tecnologia è un universo esplorabile sotto vari aspetti, ma è composto da molteplici possibilità di interpretazione. Se si parla di device, gli smartphone oggi la fanno certamente da padrone con tutte le app create appositamente per loro, ma il campo delle applicazioni in realtà è molto più largo. Gli smartphone sono uno strumento che permette di mettere in comunicazione le persone, le persone con le aziende, le aziende con le altre aziende. Oggi è la pubblicità online a veicolare, nella maggior parte dei casi, le informazioni agli utenti. Internet ha avvicinato le persone e ridotto le distanze, le culture si sono mescolate e persino l’inglese, che notoriamente è molto indietro in Italia per quanto riguarda l’introduzione scolastica e la sua conoscenza in generale rispetto al resto d’Europa, sta entrando sempre di più nella testa delle persone.»
Questo anche grazie alle serie tv e la possibilità di ascoltare i prodotti cinematografici in lingua originale…
«Indubbiamente. Abituarsi a sentire la pronuncia e la cadenza è un’applicazione pratica da non sottovalutare. Anche i social stessi sono uno strumento che nasce un po’ per perdere tempo e distrarsi ma che possono avere mille sviluppi e connotazioni. Mi ritrovo io stesso, a volte, a perdere mezz’ora di tempo a guardare contenuti. E in questo caso si spazia da video soltanto divertenti a video con contenuti molto più approfonditi e interessanti. Lo spazio di comunicazione è dunque molto ampio. Internet è uno strumento eccezionale per far conoscere attività o eventi alle persone che i canali tradizionali non permetterebbero di conoscere. Il problema è quando si sfocia nell’abuso. Lì l’utilizzo diventa fuorviante.»
Su cosa si deve intervenire, secondo lei, a livello di infrastrutture e cultura digitale in Italia?
«Il digital divide (divario digitale, ndr) è un gap che indubbiamente abbiamo rispetto a tanti Paesi stranieri. Ma questa situazione è fondamentalmente figlia di una visione politica. Gli investimenti in infrastrutture sono alla base di qualsiasi altro ragionamento, ancora prima dell’alfabetizzazione digitale dei cittadini, pur fondamentale. Per quanto riguarda le fasce di età, il giovane, nativo digitale, è senz’altro abituato ad utilizzare gli strumenti che gli vengono forniti, ma personalmente noto che nella maggior parte dei casi non è spinto a capire cosa c’è dietro determinate scelte. Spesso manca l’attitudine mentale del ragazzo a cercare le informazioni o a risolvere i problemi. La fascia d’età media, quella per intenderci che va dai 25 ai 45 anni, è al contrario cresciuta di pari passo con la tecnologia ed era già in età adulta quando questa si è sviluppata e in questo senso ha già meno difficoltà. L’anziano, infine, andrebbe aiutato semplificando le procedure.»

In che modo?
«La tecnologia deve essere semplice per essere fruita da tutti gli utenti. Quindi, per intenderci, vanno semplificati anche gli strumenti di contatto con la pubblica amministrazione. Lo Spid è una delle ultime novità introdotte (e segue la carta digitale, la firma digitale, etc.) ma i vari strumenti andrebbero unificati per permettere di accedere alla tecnologia e alla sicurezza dei dati indipendentemente dall’età dell’utente finale. Io, tanto per dire, ho avuto una esperienza caotica per riuscire a ottenere lo Spid in Posta. È assurdo che si introduca una burocrazia cervellotica per uno strumento che sta diventando praticamente obbligatorio per dialogare con la pubblica amministrazione.»
Veniamo alla sua azienda, CPartner. Come ha vissuto questi ultimi mesi?
«CPartner si rivolge alla piccola e media impresa. Realizziamo i siti internet, integrati con i social, dove le news vengono condivise con regolarità a un pubblico che può crescere in modo deciso, che segue le attività dell’azienda. È un modo per rendersi visibili, superando i limiti della tecnologia che c’era fino a qualche anno fa. La ricerca su Google è uno degli strumenti con cui farsi conoscere, ma non è certo l’unica. I social permettono di fare partnership con le aziende e spesso suggerisco azioni di co-marketing con chi realizza prodotti collegati ai propri, in modo da andare ad aggregare il potenziale pubblico di follower e ottenere così risultati migliori. Spesso, al contrario, l’azienda preferisce camminare da sola, in maniera indipendente, perché magari l’imprenditore fatica ad adeguarsi alle novità e necessità tecnologiche. In generale le persone con un’età avanzata faticano ad adeguarsi, tranne qualche rara mente illuminata o un po’ curiosa, che si accorge dei cambiamenti e si affida a un professionista per dare un futuro alla propria attività.»
In questo senso quanto sono importanti le seconde o terze generazioni di una famiglia che gestisce un’azienda?
«Le risorse interne familiari introdotte in azienda sono utili, ma spesso si tende a sopravvalutarne le capacità. Non basta aver aperto un account Instagram per sapere quali sono le dinamiche social e di marketing su quello strumento. È importante, invece, affidarsi a un professionista del settore, che può dare un contributo che può essere determinante alla crescita dell’azienda.»
In questo senso come si pone la vostra azienda all’interno del mercato?
«Sul mercato esistono molte realtà, ma ho voluto dare un’impronta fin dal nome, CPartner, per far capire al cliente che siamo seduti dallo stesso lato della scrivania e che, proprio come partner, dobbiamo creare una forma di collaborazione per raggiungere i risultati voluti. Il cliente, affidandosi ai nostri servizi e prodotti, viene tutelato nelle scelte e viene invitato ad agire nei nostri confronti come se fossimo una risorsa interna, un punto di riferimento per tutto quanto riguarda la tecnologia. C sta per computer, comunicazione e consulenza, con un significato molto ampio. La nostra è un’evoluzione dell’offerta. Mettiamo a disposizione le competenze dei nostri collaboratori, con cui di volta in volta si va a condividere un progetto, che può essere di gestione informatica pura o di realizzazione e gestione di siti e canali social.

Per ogni singolo aspetto del mio lavoro mi avvalgo della specializzazione e dell’esperienza di ogni collaboratore: il grafico, il programmatore, lo sviluppatore dei social, lo sviluppatore dei siti internet, ma anche chi è dedicato allo sviluppo delle vendite online. Quest’ultima è un’altra grossa fetta di mercato che in Italia non è ancora stata affrontata in maniera sistematica rispetto ad altri Paesi. Mi piace affidarmi a figure che abbiano esperienza e professionalità molto specifica. Io, in quel caso, assumo spesso il ruolo di commerciale e supervisore che fa da trade d’union con il cliente. In generale posso dire che chi si occupa di informatica dovrebbe esserne innanzitutto un grande appassionato. È la passione, poi, ti spinge alla ricerca continua, all’analisi e alla costante crescita. Tua e della tua azienda.»
© RIPRODUZIONE RISERVATA
