Un passo alla volta
Terzo e ultimo racconto per il ciclo "L'estate di mezzo", progetto narrativo nato per dare voce creativa a quanto la pandemia ci abbia cambiati. Tra il lockdown e i dubbi sul futuro.

Terzo e ultimo racconto per il ciclo "L'estate di mezzo", progetto narrativo nato per dare voce creativa a quanto la pandemia ci abbia cambiati. Tra il lockdown e i dubbi sul futuro.

In questa estate in cui sei niente, in cui ogni cosa rimane sospesa tra quello che eri prima e quello che pensi di poter diventare, in questa stagione che ha lo stesso sapore di gennaio, ma con le giornate più lunghe e un caldo che non è nemmeno così caldo da potersene lamentare, in questa estate mi sono persa nel disperato tentativo di trovarmi.
Ne usciremo migliori, dicevano. Io ci speravo in quei mesi di corale solitudine, tra il forno e la finestra, ho a lungo aspettato qualcuno che potesse dirmi: «non so se andrà tutto bene, ma so che tu ci proverai, davvero».
Ho passato giornate interminabili tra mura che hanno assunto il significato di casa, a ripetermi “sarà tutto diverso, sarà meglio, io sarò migliore” e quando è arrivato il momento di ricominciare mi sono trasformata in una maglietta umida dimenticata appesa al filo.
Cosa ho trovato dal vagare in circolo tra quel groviglio di pensieri disordinati che avevo arrotolato in tanti anni? Cosa ho ottenuto oltre a un inevitabile peggioramento delle condizioni del mio fegato e del mio giro vita? Non lo sapevo. Mi sono lasciata cullare da un senso di nausea costante, dall’ennesima notifica su Tinder, lampeggiante sul mio smartphone, pronta a condurmi in un’altra stanza con un soffitto che non riconoscevo, incastrata tra lenzuola dall’odore alieno da cui volevo solo scappare.
Non ho potuto evitare di interrogarmi se questo malessere fosse condiviso o se invece appartenesse solo a me, se solo io non fossi in grado di trovare una valida ragione per riprendere ogni discorso dal punto esatto in cui l’avevo lasciato all’inizio di marzo.

Mi chiedevo se fossi l’unica a sentire sulle spalle tutto il peso di un cuore che crescendo avevo messo a tacere. In questa città che brama la vita di prima, ho camminato sotto il peso di un cuore che non ero più in grado di gestire, questo organo cavo muscolare che aveva iniziato a urlare e che non riusciva a stare più al suo posto. Che per quanto facesse male riusciva a farmi sorridere riportandomi indietro nel tempo, a quella che ero, a quella bambina che non stava mai zitta e non riusciva a stare ferma nel banco, che dondolava con la sedia fino a cadere, fino a che un maestro esasperato la metteva fuori dalla porta. Ma non aveva corridoi dove sbattere questo cuore che non riusciva a riprendersi, ancora alla ricerca di un defibrillatore che lo sconvolgesse, come se tutto non fosse ancora abbastanza.
Nell’estate che si porta dentro un inverno mai finito e una primavera mai sbocciata, vagando lungo le strade di questa città in cui ho annegato me stessa, mi sono persa alla ricerca di un angolo che potesse essere solo di una me che non esiste ancora.
In queste strade che tanto hanno taciuto e ora vivono di un inarrestabile brusio, ho scavato la conca per mettere a tacere il rumore che mi portavo dentro. Un posto nuovo, che non mi conoscesse ancora: un giardino segreto in un labirinto di cemento e pietra.
Uno spazio piccolo e inesplorato, come collocato in un universo parallelo, sempre stato sotto il mio sguardo cieco, con l’odore dell’erba prima di essere tagliata, l’assordante canto delle cicale delle mie estati di bambina, la magica sensazione di un tutto ancora possibile. Attraverso gli auricolari Brunori Sas sussurrava alle mie orecchie “Ma l’hai capito che non serve a niente/ mostrarti sorridente/ agli occhi della gente/ e che il dolore serve/ proprio come serve la felicità”* mentre io cercavo di spegnere ogni mio pensiero.
È qui che ho incontrato l’espressione fisica di ogni mia paura.
(Hai paura del buio? No.
Soffri di vertigini? No, mi piace il vuoto sotto ai piedi perché compensa tutto il mondo che ho in testa.
Temi i ragni? No, mia nonna diceva che portano soldi.)

Era lì in mezzo all’erba: dieci centimetri di cavalletta verde speranza, antenne escluse, e gli occhi di qualcosa che non riconosco.
La sua corazza mi pareva contenesse in sé il profumo di ogni mia ansia, il suono di tutti i mal di testa, il tatto di un intestino irritato, la voce di un alluce che sbatte sullo spigolo del comodino, di notte, quando volevi solo andare in bagno, il colore di una mattina in cui ti ricordi di tutte le cazzate fatte la sera prima.
La guardavo e lei guardava me ed era come se tutti gli istinti fossero congelati. Ho pensato che dalla mia posizione, in quell’istante immobile in cui si celava lo spazio di un tempo, avrei facilmente potuto schiacciarla. Sarebbe stato giusto? Sarebbe stato abbastanza? Valeva davvero la pena metterla a tacere ancora una volta, magari soffocandola, sotto il peso di un libro, fingendo che fosse per sempre?
Nella sospensione di un tempo senza confini ci siamo ritrovate dipinte da Dalì in un equilibrio surreale, ed è stato proprio nel momento in cui i piatti della bilancia si sono allineati che la cavalletta ha cominciato a parlare. «Perché scappi? Dove corri senza nemmeno provare a guardarmi? Mi ricordo ancora quando mi hai soffocato dentro un sacchetto per il congelatore, mi hai lasciato seccare tra gli infissi di una vecchia finestra, mi hai scaricato nel water, mi hai spazzato con una scopa come fossi un cumulo di polvere. Una volta per scacciarmi ti sei addirittura messa i guanti da forno. Non avevo mai visto un’armatura più ridicola.»
Quelle parole dicevano di me, davvero quell’insetto mi conosceva, diceva la verità. Sentii il bisogno di controbattere con un: «È che non mi piaci».
«Perchè?», mi incalzò con la stessa perseveranza del suo stridìo costante. «Non lo so, è che non so cosa farai. Mi salterai addosso? Hai una forma che non riconosco e non capisco cosa vuoi da me, sei imprevedibile.»
«Sono poche le cose che si possono prevedere». Quel suo tono un po’ da santona mi dava sui nervi, ma non potei evitare di rispondere tutto d’un fiato. «Guarda che ho le mie ragioni, la tua specie è nota per portare distruzione. Arrivate, vi mangiate tutto e passate ad un nuovo posto da devastare. Non credo sia un caso che siate finite nella top seven delle piaghe d’Egitto.»
«A volte è indispensabile distruggere per ricominciare a costruire, a volte le macerie sono le fondamenta più solide»,
la sentìì ribattere dopo una breve pausa di silenzio. «Ma tu non lo sai, perché chiudi gli occhi e fai finta che io non esista. Non hai nemmeno avuto il coraggio di mangiarmi in quel mercato di Chiang Mai: come faccio a disgustarti se non sai nemmeno che sapore ho?».
Non avevo risposte, ma per la prima volta la cavalletta mi parve non essere estranea, apparteneva a quel prato almeno quanto me, eravamo parte dello stesso mondo, come le maree e la muffa che si fa nel sacchetto dell’umido che hai scordato di portare giù d’estate. Eravamo fatte della stessa sostanza, quella che porta gli uomini a compiere imprese magnifiche ma anche a farsi la guerre, la stessa che senza distinzione genera l’aurora boreale e i virus influenzali. Qualcuno prova a chiamare tutto questo Dio, io preferisco il termine Natura, quella forza senza contorni che porta con sé tutta la bellezza dell’universo e ogni suo terrore.
La cavalletta taceva, senza aspettare una risposta, consapevole che il nostro incontro avrebbe portato solo nuove domande.
Mi sarei alzata da quel prato per riprendere la mia via? Sarei stata nuovamente io o sarei stata ancora una volta diversa? Che sentieri avrei dovuto percorrere per ritrovarmi? Avevo una bussola con me o solo una benda sugli occhi? C’era un senso o non valeva il gioco il tentativo di trovarlo? Non lo sapevo. C’era solo una cosa che avevo imparato a fare: respirare e alzarmi, riprendere a camminare, un passo alla volta, per trovare una direzione.
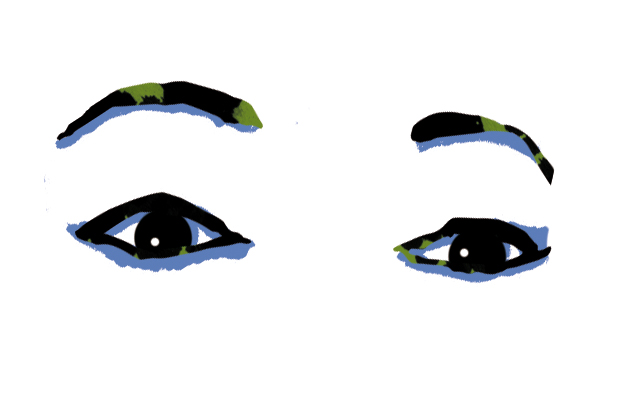
Ho un cavalletta verde in tasca. Non posso ancora lasciarla alle mie spalle, ma non fuggo, non scappo, non torno indietro. La porto sul cuore, dove risiede il mio bene e tutto il mio male. Una volta qualcuno mi disse: «Non vergognarti di temere i mostri, trova piuttosto la forza per sbirciare sotto il letto, aprire bene gli occhi e provare a vederli».
Ho guardato sotto il letto. Da vicino è meno buio.![]()
(*citazione tratta da “La Verità”, di Brunori Sas)
Qui i precedenti racconti
L’orizzonte di Ulisse, di Lorenzo Mori
Tornata a galla, di Barbara Salazer
